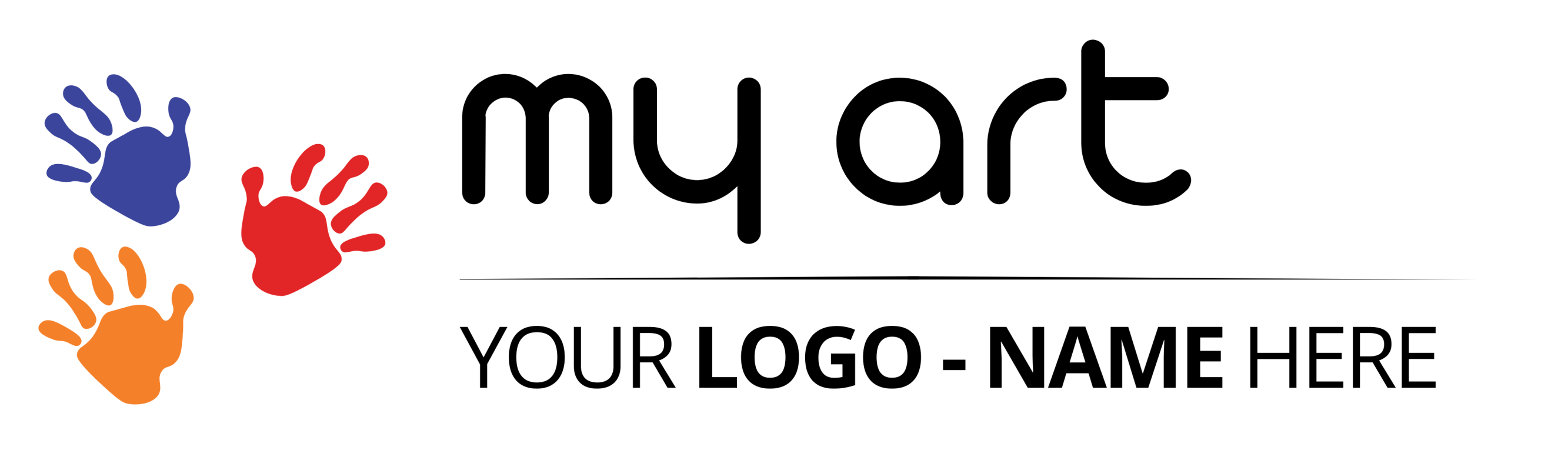Dietro le cifre si nasconde una delle emergenze più sottovalutate del Paese: quella degli sfratti per morosità e delle occupazioni abusive. I dati del ministero dell'Interno fotografano una realtà complessa. I diritti di proprietà non sempre sono posti in primo piano sia per la lentezza della macchina giudiziaria sia per l'assenza di strumenti di prevenzione, comprensivi pure di adeguati strumenti di tutela delle fragilità.
Nel 2024, secondo le statistiche del dicastero guidato dal ministro Piantedosi, le richieste di esecuzione approvate sono state 81mila (+9,8% annuo), mentre sono stati emessi 40.158 provvedimenti di sfratto in Italia, con una crescita del 2% rispetto all'anno precedente. Di questi, circa 30mila (75%) erano dovuti a morosità e il 47% si è concentrato nelle città capoluogo. Gli sfratti eseguiti sono stati 21.337, in linea con il 2023. La classifica regionale è guidata dalla Lombardia (4.802, +41,6% annuo), seguita da Piemonte, Lazio, Emilia Romagna e Veneto.
Dietro ogni numero c'è una storia di difficoltà e, dall'altro lato, una perdita patrimoniale che spesso resta invisibile. Un'indagine condotta nel 2021 dall'istituto Emg ha stimato che un inquilino moroso smetta di pagare in media cinque mensilità, per un valore di 1.740 euro per caso. Ma si tratta solo del danno immediato: nei grandi centri urbani, dove i canoni medi superano i 1.500 euro al mese e le procedure giudiziarie durano fino a un anno, la perdita effettiva per un proprietario può oscillare tra i 10mila e i 20mila euro, includendo spese legali, danni agli immobili e mancato reddito da locazione. Applicando questi parametri al numero totale delle richieste di sfratto per morosità (oltre 60mila casi su base biennale), il danno economico diretto generato si colloca in una forchetta tra 650 milioni e 1,2 miliardi di euro.
Una cifra imponente che non tiene conto dei costi indiretti: le spese pubbliche per la gestione giudiziaria, gli oneri di sicurezza per gli sgomberi, l'assistenza abitativa per le famiglie sfrattate e la perdita di valore complessiva del mercato della locazione, sempre più percepito come rischioso. È una voragine economica che coinvolge privati e Stato e che si traduce in un rallentamento della rotazione degli immobili e in un minor gettito fiscale legato ai redditi da affitto.
La morosità incolpevole, dovuta a perdita del lavoro o emergenze familiari, continua a rappresentare una quota significativa. Tuttavia, una parte crescente dei casi deriva da situazioni di occupazione abusiva, soprattutto nelle periferie metropolitane. Secondo Nomisma e Federcasa, nelle sole grandi città si contano almeno 50mila unità abitative sottratte al mercato legale (di cui 30mila di edilizia residenziale pubblica), con danni economici stimabili in ulteriori centinaia di milioni di euro l'anno tra mancati canoni, costi di recupero e degrado urbano.
Il problema non è solo sociale, ma anche sistemico: un circolo vizioso in cui il rischio di insolvenza spinge molti proprietari a ritirarsi dal mercato o a preferire l'affitto breve turistico, riducendo l'offerta di abitazioni a lungo termine. Così, mentre i canoni salgono e la domanda di case in affitto cresce, la disponibilità reale di alloggi si restringe.
Il nuovo decreto Sicurezza prevede misure più severe contro le occupazioni abusive e procedure semplificate per la restituzione degli immobili, ma il vero nodo resta la lentezza dei tribunali. Una procedura di sfratto può ancora durare da sei mesi a un anno dopo la convalida, prolungando l'esposizione economica del proprietario e aumentando la perdita complessiva. Il decreto potrebbe ridurre significativamente il danno economico, ma come ogni riforma vera non è a costo zero.
L'effetto complessivo è un mercato distorto, in cui la proprietà immobiliare diventa al tempo stesso fonte di perdita economica per i locatori e di precarietà per gli inquilini. Il bene rifugio degli italiani per eccellenza diventa così l'investimento più a rischio.